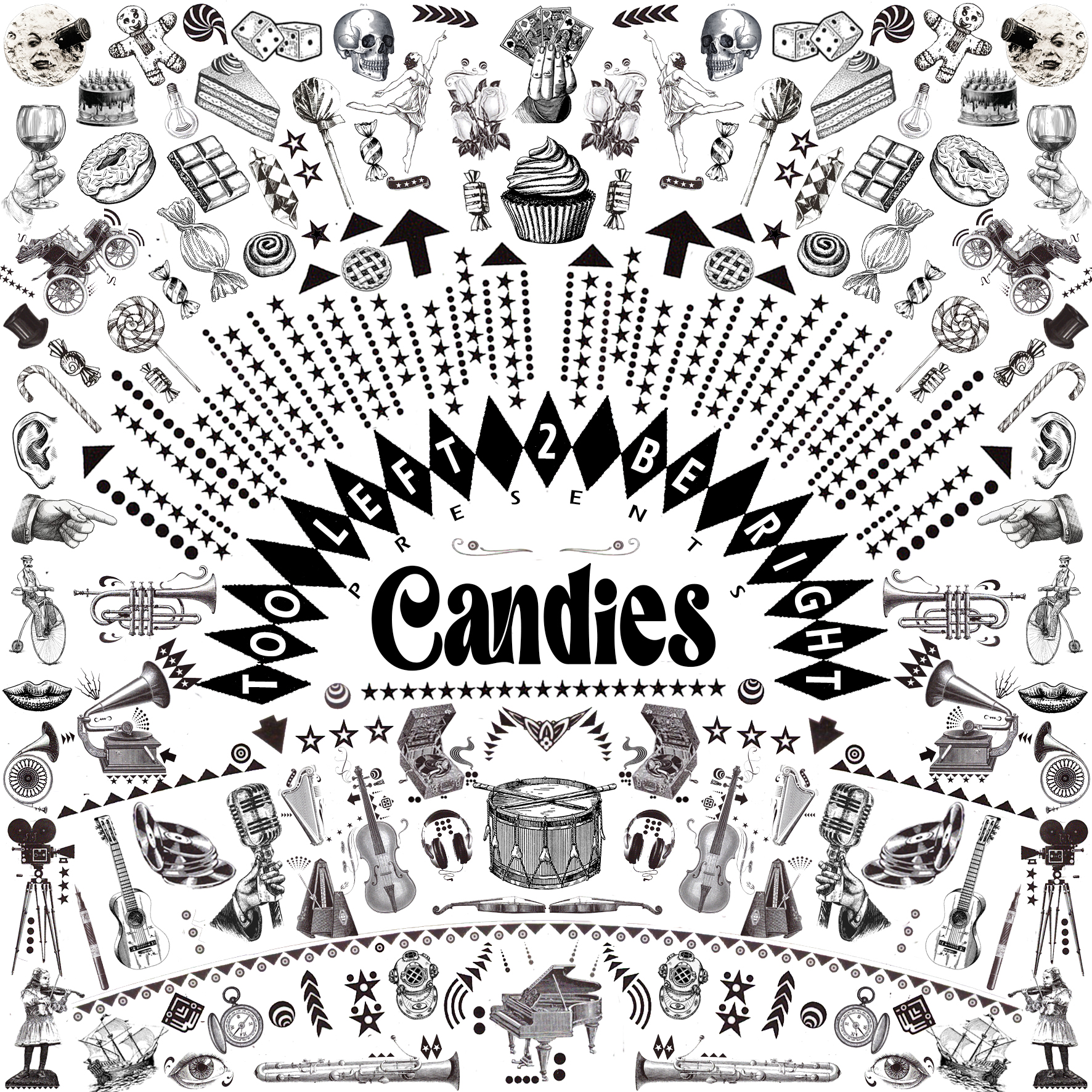Uno degli aspetti migliori dello scrivere recensioni, è notare l’evoluzione delle band. Nello specifico parlo dei Too left 2 be right. Il loro ultimo Candies, in uscita nel mese di maggio, è davvero un gran passo avanti. Il sound, fin dal primo ascolto, come anche il songrwrtiting, è decisamente più maturo, più personale, più ricco e stimolante rispetto ai lavori precedenti. Vero è che di tempo dal disco scorso ne è passato. Ultimo disco è targato 2016. Ma è anche segno di come la band non sia rimasta ferma. Tutt’altro. Lo studio incessante degli strumenti, voce inclusa, si sente. I brani rispetto al passato risultano più fluidi, meglio amalgamati, con trame più fitte ed architetture più complesse.
Non è mutato l’ambito in cui i nostri si muovono. Sempre crossover di ottima fattura. Altra caratteristica è la sottolineatura della presenza di elementi elettronici. Presenti anche nei cd precedenti ma non in modo così ben integrato. È stato poi abbandonato quel velo oscuro che ha caratterizzato il primo disco. Il motivo è anche il cambio di prospettiva dei testi. Da ‘rabbiosi’ a più aperti alla speranza. La sensazione che rimane dopo l’ascolto è quella di una band meno impegnata a dimostrare, nel primo lavoro c’erano molti più cambi repentini al limite del prog, ma più concentrata a costruire buone canzoni. La stessa voce è cambiata in meglio. Meno urlata, maggiormente contestualizzata. Più incisiva.
Il disco apre con il singolo, Candies. La base dell’intro è elettronica, poggiata su una base di pianoforte. Si prosegue, prima dell’ingresso della chitarra con suoni pieni, con un fraseggio che richiama i fab four. Il ritmo si fa incalzante subito dopo. Chitarra piena, toni più forti. Ma non è la struttura definitiva del brano. Il quale, ha moltissimi cambi al proprio interno. Subito dopo lo special distorto si entra in un terreno più jazzato, fusion quasi al quale si alterna, in pieno stile Too left, una parte più hip hop.
Anche in questo caso menzione alla voce. Perfetta. Arriva quindi il ritornello, punk rock. Aperto, melodico, orecchiabile. Di nuovo lo special che indurisce i suoni per fare spazio alla nuova strofa. Il secondo break jazzato si presenta un po’ più rabbioso. Menzione alla batteria di Mauro Borioni che accompagna con un fraseggio quasi samba. Ottimo il solo che approfitta del passaggio. Poche note ma posizionate perfettamente. Si passa a Maybe you both. Un punk rock leggero per i suoni, ma complesso per la struttura nel so insieme.
Numerosi sono i cambi e gli inserti, a partire dagli interventi elettronici. L’andamento complessivo rimane molto saltellante, aperto con un riff di tastiera iterante che accentua la melodia. Ottimo lo special centrale che passa repentinamente da suoni pienamente distorti ad un frangente completamente acustico. Ma non è finita. Si cambia di nuovo. Rientra la chitarra distorta. Prima in modo leggero per poi esplodere in un riff monolitico. Tio biab è uno brani più scuri del disco. Stilisticamente non è definibile. Chitarra acustica sostenuta da quella elettrica con tastiera lunga in sottofondo.
La distorsione quasi non si sente. Neppure quando il brano apre al ritornello. I toni. Pur se più elettrici, si tengono sempre piuttosto bassi. Scelta perfetta per dare giusta enfasi alla composizione nel suo insieme e metterla al servizio della narrazione. All’ennesimo ascolto si potrà notare come la base ritmica non è quasi mai uguale a se stessa. Ora accenti, poi stacchi su linee proprie, poi lineare. Lodevole il break solo voce e tastiera che introduce al ritornello in crescendo.
Ritmi sincopati accompagnano al finale. Si passa a Sideway down. Cambiano le atmosfere. Il riffing si fa pesante. Idem per la tastiera. Tuttavia è solo l’introduzione. Con l’ingresso della voce le distorsioni scompaiono per lasciare spazio a ritmiche complesse in cui domina la sezione ritmica, in particolar modo la batteria da una parte. Dall’altra è il basso a tenere banco portando l’accompagnamento principale sulla strofa. Sul suo tappeto poggiano le tastiere. Il compito della chitarra è quello di accompagnamento con diverse armonizzazioni.
Circa a metà sono proprio basso e batteria ad essere protagonisti. La chitarra interviene con armonici e un arpeggio leggermente dissonante. L’elettronica sottolinea il ritorno della voce prima della deflagrazione finale. Chitarra pienamente distorta, batteria incisiva, dritta, come è giusto che sia. Questo incedere possente, diluito solo dalla melodia della voce, porta alla chiusura. Half a glass of wine gioca sulla contrapposizione chiaro scuro. L’inizio e darkeggiante, nero come la pece. La chitarra acustica alleggerisce leggermente i toni ma non apre alla luce. Per questo si dovrà attendere il ritornello e le tastiere. Suoni elettronici, accompagnamento dissonante della chitarra riportano sulle coordinate iniziali.
A fare la differenza è sempre il basso che risulta portante per buona parte del brano. L’intervento della chitarra solista è limitato a poche note col wha. Nuovo cambio. Si abbassano i toni. Si torna in acustico prima di risalire. Ma solo di intensità. Chiusura repentina. Don’t call me by my first name riporta in auge la sei corde. Non in modo pesante. I suoni sono complessivamente molto misurati, mai eccessivi. Di novo elettronica. Loop su controtempo di batteria.
Per la voce si presenta il fantasma del primo amore del nostro, Mike Patton. Che non è un male, in quanto citazione circostanziata. I ritornelli in questo disco hanno la capacità di essere tutti cantabili e memorizzabili. Il solo è affidato al synth che porta al conclusione. Monoface dice è un altro brano completamente crossover. Infiniti cambi, chitarra in levare. Ritmi che si alternano tra il rock e il latin senza che vengano a mancare gli interventi elettronici. Per certi versi potrebbe essere considerato un brano a mezza strada tra surf e funky. Ma sono solo etichette. Più che lodevole lo special a ¾. Batteria percussiva, nel senso letterale del termine, vengono utilizzate delle percussioni. Voce in crescendo, chitarra zitta. Il finale è invece affidato alla psichedelia. Tastiere con suoni lunghi.
Supehero of the day riporta su margini più rockeggianti. Ma non più lineari. Tutt’altro. I ritmi si frantumano. Fino ad essere raccolti da un nuovo cambio che porta il marchio del jazz. Si cambia ancora. Dopo il jazz si inserisce una parte quasi industrial. Alternarsi che procederà fino al finale che nasconde una nuova sorpresa. Un incattivimento generale caratterizzato da un urlo della voce. È ‘solo’ un passaggio che riapre ad una nuova strofa. Il ritornello termina il brano. Si procede al penultimo step.
Dig up the roots. Di nuovo ritmi sincopati. Basso e chitarra unisono. Una sorta di poliritmia con la batteria. Ritornello hard rock. Segue il ritornello un pregevole stacco quasi jungle su cui si poggiano suoni elettronici subito surclassati dalla chitarra. Questo passaggio si alterna per un paio di giri fino a venire fagocitato dalla strofa. Sul finale si fanno presenti suoni liquidi, nel vero senso della parola. Suoni che caratterizzano fino alla fine la canzone in crescendo. Harm a hair è l’ultimo giro di questo disco.
Una composizione pesante, caratterizzata da dissonanze, ritmi spezzati, voce evocativa. Il tutto strumentale ad un ritornello aperto. Azzeccatissimo lo stacco ritmico a circa metà canzone. Questo apre la strada all’a solo di chitarra. Melodico, in puro stile anni ’90 a richiamare in qualche modo i Blind melon. Si torna a ritmiche più pesanti. Fino a quando non c’è l’ennesimo cambio. Torna l’elettronica. Solo per pochi giri ma riesce a destabilizzare quanto basta prima del ritornello a suoni pieni.
Concludendo. Un disco davvero notevolissimo quello dei Too left 2 be right. Complesso, melodico, articolato, mai scontato. Suonato in modo egregio, registrato ancore meglio. Gli inserti elettronici, pur non essendo una novità per i nostri, davvero ottimamente si sposano al loro stile non identificabile. Diciamo crossover perché non c’è un altro termine. Potremmo semplicemente parlare di 2 be left music. E non sarebbe sbagliato. Certo i suoni dei nostri sono assolutamente identificabili e riconoscibili. Un disco che non si assimila al prima ascolto.
Come neppure al decimo. Ne serve qualcuno in più per riuscire ad iniziare ad orientarsi nel marasma di richiami e cambi. Il che è solo positivo. Vuol dire che non siamo di fronte ad un lavoro che annoia o che possa esaurire la propria vena di sorprese. Un disco consigliato ai più, in particolar modo chi cerca ascolti non banali, stimolanti, con suoni diversi chge spaziano dalla jungle al jazz passando per il metal e l’hard rock.